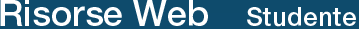

Ricerca visuale e trasformazioni socio-culturali
Autori:
A. Frisina
ISBN: 9788860084156
Vai alla scheda libro
BENVENUTI nell'area on line di “Ricerca visuale e trasformazioni socio-culturali” dove troverete i materiali multimediali che corredano il corso.
Capitolo 1
Premessa
I materiali qui presentati a titolo esemplificativo provengono dalle mie etnografie con un gruppo di giovani pentecostali di Verona originari del Ghana (ottobre 2009- febbraio 2011), svolta insieme a Giusy Boateng, e con un gruppo di giovani sikh della provincia di Reggio Emilia originari del Punjab/India (aprile 2011-novembre 2012), svolta con Barbara Bertolani. In entrambi i casi ci siamo avvalse nella fase di montaggio della preziosa collaborazione di Stefano Collizzolli (ZaLab), esperto di video partecipativo.
es. 1 Etnografie visuali collaborative
“Nonostante i sogni di alcuni scienziati sociali per un film ‘panoptico’ che riesca a dare un resoconto esaustivo di un evento, la videocamera può registrare solo una singola prospettiva alla volta. Come nella scrittura, il film-maker deve quindi procedere in modo analitico, costruendo una nuova realtà a partire da frammenti, vedendola sia con la mente che con gli occhi. In ogni momento vengono rifiutate centinaia di alternative per ottenere una comprensione più specifica e spesso idiosincratica”(David MacDougall 2006, 34).
Giovani pentecostali italo-ghaneani in dialogo
Tra le principali novità della crescente diversità religiosa in Italia c’è la presenza delle chiese neo-pentecostali africane (Pace e Butticci 2010). Queste chiese sono collocate frequentemente in spazi marginali, periferici e, in particolare, quelle frequentate nella nostra ricerca (Ambassadors of God to All Nations e Christ Apostolic Church) si trovano nella campagna urbanizzata veneta. I capannoni industriali, svuotati dalla crisi economica, si rianimano diventando luoghi di culto e di aggregazione per i migranti africani e ora anche per i loro figli. Tra questi c’è un gruppo di giovani ventenni che si sentono anche italiani/e e vivono questa invisibilità come una discriminazione.
La motivazione principale per impegnarsi in un percorso di ricerca collaborativo (che si è servito di osservazione partecipante, interviste discorsive e focus group), allora, è legata alla ricerca di una visibilità strategica (si veda il cap. 6)che faciliti un cambiamento innanzi tutto culturale della società italiana.
Ciò consentirebbe alla società italiana di pensarsi diversamente, non utilizzando più il cattolicesimo come collante degli italiani, o per dirla con E. Pace come “l’idea romantica per far sentire unita una nazione divisa”, a partire dallo storico divario Nord-Sud, e di riconoscere la pluralità dei modi in cui essere italiani ed essere cristiani. Si tratta di una sfida particolarmente impegnativa in un contesto come quello veronese (in cui l’estrema destra è influente), dove anche i protestanti storici (come i valdesi) non hanno mai terminato di resistere a provocazioni fasciste affermando il loro diritto alla libertà religiosa.
Una presenza crescente di chiese invisibili
Giovani protestanti alla ricerca di pluralismo religioso a Verona
Nel dialogo tra giovani pentecostali italo-ghanesi e loro coetanei protestanti italiani, emergono sia esperienze simili che differenze. Da una parte, i giovani valdesi come i giovani pentecostali si sentono incompresi dai cattolici e loro stessi rimarcano una distanza dal cattolicesimo. Dall’altra, esprimono sensibilità diverse ma non inconciliabili (il modo in cui si relazionano a Dio per i valdesi è più razionale, per i pentecostali più emozionale, ma “Ciò che conta è il cuore, che si preghi urlando o che si preghi in testa” dice Theo). Raccontare la ricerca attraverso video come questi permette di “avvicinare” maggiormente il pubblico ai temi trattati e coinvolgerli anche emotivamente. Ad esempio, l’uso del “primo piano” crea una prossimità a facce e corpi altrui che è meno comune sperimentare nella vita quotidiana, dove una vicinanza simile è circoscritta alle relazioni più intime. D. MacDougall, che ha sottolineato la natura polisensoriale della conoscenza costruita attraverso i film etnografici, parla di “visione prensile” e sostiene:
“Nell’esagerazione della prossimità, il primo piano porta nel cinema una quasi-tattilità assente nelle relazioni umane ordinarie. Quando noi incontriamo gli altri negli scambi quotidiani non esploriamo le loro facce con i nostri polpastrelli, ma il cinema ci porta vicini al fare ciò (…). L’individualità dei visi nei film crea anche maggiori possibilità di identificazione psicologica”(Ibidem, 2006, 22 e 55).
Es. 2 Fotointerviste
La rappresentazione pubblica dei sikh in Italia è caratterizzata dallo stereotipo positivo dei pacifici e bravi lavoratori (Denti, Ferrari e Perocco 2005), che a volte è stato usato contro altri migranti, in primis i musulmani, per contrapporre gli integrati vs gli inassimilabili, una religione rappresentata come intrinsecamente non-violenta vs una religione violenta. La differenza religiosa dei sikh è stata inoltre folklorizzata, perché il ballo (bhangra) o le arti marziali (ghatka) praticate dai giovani sikh “piacciono agli italiani” e il multiculturalismo di mercato (Colombo 2002) sembra facilitare la convivialità. Infine, negli ultimi anni i cittadini sikh hanno saputo fare un uso pubblico della memoria della Resistenza al nazi-fascismo che li includesse nella storia italiana, commemorando da anni i “liberatori sikh”, non solo il 25 aprile, ma anche il 25 agosto al cimitero monumentale di Forlì dove si trovano i caduti della seconda guerra mondiale, tra i quali numerosi soldati sikh.
Con le mie fotointerviste ai giovani sikh italo-indiani ho voluto comprendere come la visibilità pubblica dei sikh e in particolare quella legata alla commemorazione del 25 agosto sia vissuta da una prospettiva generazionale.
Nel primo estratto, Amrit racconta della commemorazione di Forlì come un’esperienza positiva ed è soddisfatto per il suo ruolo pubblico nel “ricordare chi ha difeso l’Europa” e nello “spiegare la sua religione” agli italiani.
Il monumento ai “liberatori sikh”: oltre alle fotografie della commemorazione del 25 agosto, ho usato il seguente video come domanda visuale:
http://www.youtube.com/watch?v=63uAFeNeoWY&feature=player_embedded
Nel secondo estratto di intervista, Balginder esprime le sue critiche verso la statua per passare ad una più generale critica alla “mentalità dei genitori”, per chiedere maggiore protagonismo nella comunità religiosa e fare rivendicazioni legate all’essere sikh in Italia (v. libertà di indossare i simboli religiosi senza restrizioni, incluso il kirpan, la spada).
Le interviste si sono svolte in una pasticceria indiana vicina al tempio sikh di Novellara (Reggio Emilia), frequentato da diversi giovani italo-indiani e in particolare da un gruppo di ballerini banghra che si ritrovano a fare le prove nel retrobottega.
Bibliografia minima su sikh e pentecostali in Italia
DENTI D., FERRARI M., and PEROCCO F. (eds) (2005), I Sikh . Milano: Franco Angeli
PACE E. & BUTTICCI A. (2010), Le religioni pentecostali, Carocci, Roma.
Capitolo 2
1. Risorse utili
L’associazione internazionale dei sociologi visuali, Internation Visual Sociology Association
ivsa@visualsociology.org (per ricevere la newsletter)
L'ISA (International Sociological Association) ha un gruppo di sociologi visuali che pubblicano una newsletter ("Visual Sociology"), qui reperibile:
http://www.isa-sociology.org/wg03.htm
La rivista di riferimento
Visual Studies
http://www.tandfonline.com/action/aboutThisJournal?show=aimsScope&journalCode=rvst20
Segnalo in particolare l’articolo di P. Parmeggiani sull’uso delle nuove tecnologie nella ricerca visuale
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14725860902732991#preview
Altre riviste in cui è possibile pubblicare ricerche visuali
Forum Qualitative Social Research (open access)
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs
Per un numero monografico sul tema “Visualising Migration and Social Division: Insights From Social Sciences and the Visual Arts”
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/issue/view/34
Visual Ethnography (pubblica saggi in cinque lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese)
http://www.vejournal.org/?journal=vejournal
Ethnographiques
http://www.ethnographiques.org/
Dalla sua creazione nel 2002, questa rivista ha offerto ai ricercatori la possibiltà di pubblicare anche i materiali audiovisuali prodotti dal lavoro sul campo. Il suo impegno nel promuovere nuove forme di scrittura etnografica associata all’uso di diversi media è leggibile in primo luogo in questo numero monografico dedicato alle nuove tecnologie
http://www.ethnographiques.org/2008/Chevalier,Mayor,Schoeni
Segnalo anche un recente numero monografico su “Filmer le travail : chercher, montrer, démontrer”
http://www.ethnographiques.org/2012/Gehin,Giglio-Jacquemot
Infine, per conoscere le risorse open source esistenti per fare ricerca visuale (come ad esempio “Image Interviewer” o “Video Grok”), si rimanda al sito
http://anthromethods.net
2. La fotografia documentale
L’immenso archivio visuale della Library of Congress (USA)
http://memory.loc.gov/ammem/fsowhome.html
Una delle fotografia documentali più illustri sul periodo della Grande Depressione
La “Madre migrante” di Dorothea Lange
Frisina - Migrant Mother (Dorothea Lange)
Nell'archivio disponibile on line è possibile vedere non solo documenti visuali sulla povertà, ma anche sulle discriminazioni
http://www.loc.gov/rr/print/list/085_disc.html
Ecco un paio di esempi:
Durham, North Carolina. May 1940. Foto di Jack Delano
Frisina - FSA(on discrimination2)
Memphis,Tennessee. October 1939. Foto di Marion Post Wolcott
Frisina - FSA(on discrimination)
3. L’uso della fotografia nella ricerca etnografica
Luiz Achutti e la ‘fotoetnografia’ (2004, Paris), ovvero “l’uso della fotografia come una forma narrativa speciale delle pratiche etnografiche”
http://www.fotoetnografia.com.br/
4. L’uso interattivo e riflessivo della fotografia
La ricerca sugli “spazi vissuti nel tempo libero” dei Giovani Musulmani d’Italia (GMI)
Esempi di produzione soggettiva di immmagini fotografiche, scattate dalle ragazze che nell’associazione dei GMI sono le più numerose e attive.
Per saperne di più sui giovani musulmani figli dell’immigrazione in Italia, si veda A. Frisina, Giovani Musulmani d’Italia, Roma, 2007.
La mia palestra. Shaima, appassionata karateka, sezione di Torino.
Per vedere le fotografie della sezione di Bologna accompagnate dalla voce di Linda Elian (una delle protagoniste),
http://www.vimeo.com/22922917
Questo video è stato mostrato in diverse conferenze e incontri pubblici, sia dalle dirette interessate (le GMI) che dalla ricercatrice, ed è stato recepito come una dichiarazione d’amore per la propria città da parte di ragazze musulmane bolognesi.
Capitolo 3
1. L’orizzonte postcoloniale: per una contropolitica della memoria
Angelo Del Boca (2005) ci ricorda che il mito degli “italiani brava gente” ha coperto troppe infamie: le brutalità compiute nella guerra al “brigantaggio” nel periodo dell’unificazine d’Italia, i massacri dell’esercito italiano in Libia e in Etiopia, il tentativo di “pulizia etnica” contro slavi e sloveni sul confine orientale, il terribile eccidio compiuto dai militari italiani ad Addis Abeba dopo il fallito attentato al generale Rodolfo Graziani…
Per risvegliare la memoria sui crimini compiuti dal fascismo, si veda il documentario Fascist Legacy della BBC, disponibile on line (doppiato in italiano):
Frisina - la difesa della razza
Italia, 5 agosto 1938. Copertina del primo numero de La difesa della razza.
La spada rappresenta il potere dello Stato, chiamato a separare e difendere la razza ariana dal pericolo di contaminazione portato dagli ebrei e dai “negri”.
Nel 1937 vi fu il primo provvedimento segregazionista preso dal regime fascista: le relazioni “d’indole coniugale” tra “soggetti di razza diversa” venivano puniti con la reclusione da 1 a 5 anni. Eppure, l’ “avventura imperiale” era stata sistematicamente accompagnata da allusioni sessuali che incoraggiavano a comprare/consumare i corpi neri come fossero una merce.
La propaganda fece largo uso dell’immagine, in un paese in cui il tasso di analfabetismo era ancora molto alto.
Dal “viaggio visivo nel novecento totalitario” (assemblea regionale Emilia Romagna, percorsi di cittadinanza)
Assemblea regionale Emilia Romagna
Frisina - DeSetarazzismofascismo
Italia, 1935-1936. Cartolina “umoristica” di E. De Seta, destinata ai militari italiani in Africa Orientale.
“Le metafore sessuali e di genere sono state utilizzate per rappresentare le relazioni di potere tra colonizzatori e colonizzati: mentre le terre da conquistare subivano un processo di esotizzazione e di femminilizzazione, le donne africane apparivano come un bottino di guerra per i soldati italiani (…). Il possesso del corpo delle donne nere coincideva con la conquista del territorio coloniale- un territorio “vergine” da “penetrare”- e la soddisfazione del desiderio maschile coincideva con la vittoria militare del fascismo” (Sabelli 2010, 106).
R. Siebert (2012, 182) sottolinea che sessismo e razzismo hanno dei tratti in comune “rispetto alla fondamentale dinamica della naturalizzazione di relazioni che invece sono culturali e sociali” e cita S. De Beauvoir (1999, 23):
L’eterno femminino equivale all’anima negra e al carattere ebraico. (…) Ci sono analogie profonde tra la situazione delle donne e quelle dei negri: un medesimo paternalismo emancipa oggi le une e gli altri, e la casta dominante in passato vuole tenerli “al loro posto” cioè al posto che essa ha scelto per loro; in ambedue i casi si profonde in elogi più o meno sinceri sulle virtù del “buon negro” dall’anima incosciente, infantile, giocosa, del negro rassegnato e della donna “veramente donna”, cioè frivola, puerile, irresponsabile, la donna sottomessa all’uomo. Nell’un caso come nell’altro la classe dominante trae argomento dallo stato di fatto ch’essa stessa ha creato.
2. Il “diritto di guardare” e i “neorealismi antifascisti” (1917-presente)
Un esempio memorabile di “neorealismo antifascista” è il film di Gillo Pontecorvo, “La Battaglia di Algeri” (1966), che vinse il Leone d’Oro alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Racconta la lotta di liberazione anticoloniale del popolo algerino e fu censurato per anni dalla Francia.
Per vederne il trailer in italiano:
La battaglia di Algeri
Mirzoeff (2011) ricorda un altro film che contiene sguardi proibiti, che sfidano la visualità coloniale, mostrando la violenza dei colonizzatori che si supponeva dovesse restare invisibile. Si tratta di “Ho otto anni” (Yann Le Masson, Olga Poliakoff et René Vautier, 1961) un documentario che è il prodotto di una nuova strategia terapeutica di visualizzazione che Fanon stava sperimentando nel suo lavoro clinico con i profughi algerini a Tunisi.
All’inizio del film si vedono volti di bambini algerini e il fuoco è sui loro sguardi, fino ad allora ignorati ed irrilevanti. Questi sguardi poi si materializzano nei loro disegni, che mostrano la loro esperienza traumatica e di riflesso tutta la violenza coloniale.
"Ho otto anni" (Le Masson, Poliakoff, Vautier, 1961)
Anche “Leone del deserto” (1981), il film di Mustapha Akkad dedicato ad Omar Al-Mukhtar, l’eroe della resistenza anticoloniale libica fu censurato dall’Italia per trent’anni.
Ora è visibile integralmente on line, in italiano
"Leone del deserto" (M. Akkad, 1981)
3. Immaginari dominanti, sguardi oppositivi
Sul potere riarticolatorio del consumatore-produttore di immagini, si veda il lavoro di Mauro Biani sui poster elettorali della Lega Nord.
Frisina - manifesto lega nord welfare
Quando la realtà supera la fantasia (per ricostruire la storia dello pseudo poster leghista che incitava alla tortura dei clandestini):
4. Esplorando un futuro digitale
I video di Ali Darwish (Muslim Ali Tv) citati nel Cap. 3.
-“Genitori-Tutorial islamico”
http://www.youtube.com/watch?v=ZyM58akHf60
-“Se ti dico Siria?”
http:// http://www.youtube.com/watch?v=6ykE76D5GzE
Capitolo 4
Il video partecipativo e il photovoice coinvolgono gruppi di partecipanti per produrre immagini in movimento o fisse e creare le condizioni perché le loro voci siano ascoltate –perché rese visibili e coinvolgenti dal punto di vista emotivo- nello spazio pubblico.
1. Il video partecipativo
High C. 2010 What is Participatory video?
http://www.methodspace.com/video/what-is-participatory-video-by
(This video is from the 4th ESRC Research Methods Festival, 5-8 July 2010, Oxford).
Le origini: Il progetto dell’isola di Fogo (CA)
http://www.nfb.ca/film/introduction_to_fogo_island
Questo film introduce il processo dell’isola di Fogo Island/Newfoundland, un esperimento pioneristico di come la produzione video partecipativa possa servire da catalizzatore per il cambiamento sociale. Vengono presentate le informazioni di base sull’isola canadese e si spiega perché è stata scelta per il progetto.
Un altro film prodotto durante il progetto:
http://www.nfb.ca/film/children_of_fogo_island/
Le pratiche più recenti del National Film Board of Canada:
http://blog.nfb.ca/blog/2010/09/28/introducing-media-literacy-to-the-children-of-fogo-island/
http://filmmakerinresidence.nfb.ca/
Quest’ultimo costituisce il versante più innovativo, quello dei documentari web.
In Italia:
ZaLab
http://www.zalab.org/tipo-it/2/#.UX6afFKdOSp
Due frammenti da un percorso di video partecipativo (“Come esseri umani e cittadine”, 2008) che ho realizzato insieme a ZaLab/Stefano Collizzolli per disseminare i risultati di una ricerca europea (WAVE) sulle trasformazioni dei sistemi di welfare e le interazioni tra cittadine/i di origine immigrata e operatori dei servizi socio-sanitari, in particolare nell’ambito della salute riproduttiva.
2. Il photovoice
Wendy Ewald e le origini del photovoice nella fotografia collaborativa
http://literacythroughphotography.wordpress.com/wendy-ewald/
Alcuni esempi del suo lavoro pionieristico con i bambini ed un video di una sua lezione
http://mediaofzion.squarespace.com/home/2010/8/10/wendy-ewald-literacy-through-photography.html
Un esempio di photovoice nella ricerca sociale: il lavoro dell’antropologa Krista Harper con i Rom ungheresi
http:// http://works.bepress.com/krista_harper/18/
(si tratta di un articolo open access)
http://works.bepress.com/krista_harper/20/
(una presentazione power point basata sul suo nuovo libro con Aline Gubrium, “Participatory Visual and Digital Methodologies”, Left Coast Press, Marzo 2013).
In Italia:
Dalla ricerca azione “Una nuova generazione del Nord Est”, Annalisa Frisina
Video realizzato con un gruppo di ragazze (composto da una prevalenza di giovani ricongiunte alle loro famiglie migranti in età adolescenziale) in un istituto tecnico di Padova. Racconta che cosa c’è dietro la maschera delle giovani belle sorridenti e prova a dire in pubblico la solitudine, il bisogno di cambiamento e le fatiche quotidiane per essere considerate cittadine alla pari, a partire dalla scuola.
3. Altre risorse
Using Participatory Visual Methods
Naomi Richards, Department of Sociological Studies, University of Sheffield
http://www.socialsciences.manchester.ac.uk/morgancentre/realities/toolkits/participatory-visual/
Capitolo 5
Nel secondo incontro di gruppo del photovoice le immagini prodotte e selezionate dai partecipanti alla ricerca vengono usate come fotodomande per facilitare l’interazione.
Grazie alla forza emotiva delle immagini e alla loro polisemia, le fotografie mettono in moto sguardi conflittuali che lasciano emergere nuovi processi di identificazione e differenziazione tra i partecipanti alla discussione.
Questo primo video è stato realizzato in un istituto tecnico di Verona (da un gruppo omogeneo di ragazzi, con e senza background migratorio).
Oltre alla produzione soggettiva sui tre temi della ricerca “Una nuova generazione del Nord Est” (cfr. Cap. 4) è possibile ascoltare il dialogo conflittuale tra Igor (di origine brasiliana) e i suoi compagni su come vedono le scritte razziste disseminate nel territorio in cui vivono.
Igor vuole sentirsi a casa e con la sua fotografia del simbolo di Forza Nuova vuole responsabilizzare tutti i cittadini (e i suoi compagni di discussione) a non “assuefarsi” all’intolleranza.
Questo secondo video è stato realizzato in un istituto professionale di Padova (da un gruppo omogeneo di ragazze, con e senza background migratorio).
E’ stato intitolato “Il Salto”, in omaggio ad una fotografia (sull’amicizia, cfr. Cap. 4) con la quale tutte (autoctone e figlie delle migrazioni) si sono riconosciute.
Nel video è possibile ascoltare il dialogo conflittuale tra Ajten (di origine macedone) e le sue compagne su come a scuola sia possibile o meno sentirsi cittadine al tempo del “pacchetto sicurezza” (cfr. par. 5.2).
Capitolo 6
1. Comunicare il photovoice
Questo è uno dei due video presentati a Verona (cfr. par. Osservare la ricezione delle immagini nella sfera pubblica).
2. Questioni etiche: “Le cose che non posso cambiare”
Questo film è considerato il precursore del programma Challenge for Change del National Film Board of Canada (cfr. video partecipativo, cap. 4). L’intento è quello di seguire da vicino una famiglia in condizioni socio-economiche svantaggiate per fare “un’anatomia della povertà nel Nord America” negli anni sessanta.
Tuttavia, dal punto di vista etico è stato un film problematico, perché la famiglia Bailey non ha avuto alcun controllo sulla sua autorappresentazione.
“The things I cannot change” è visibile nel sito:
http://www.nfb.ca/film/things_i_cannot_change/
In seguito è stato realizzato un sequel che intende raccontare che cosa è accaduto alla famglia Bailey di Montreal 18 anni dopo la realizzazione del primo documentario.
“Courage to change” è visibile nel sito:
http://www.nfb.ca/film/courage_to_change
APPENDICE

